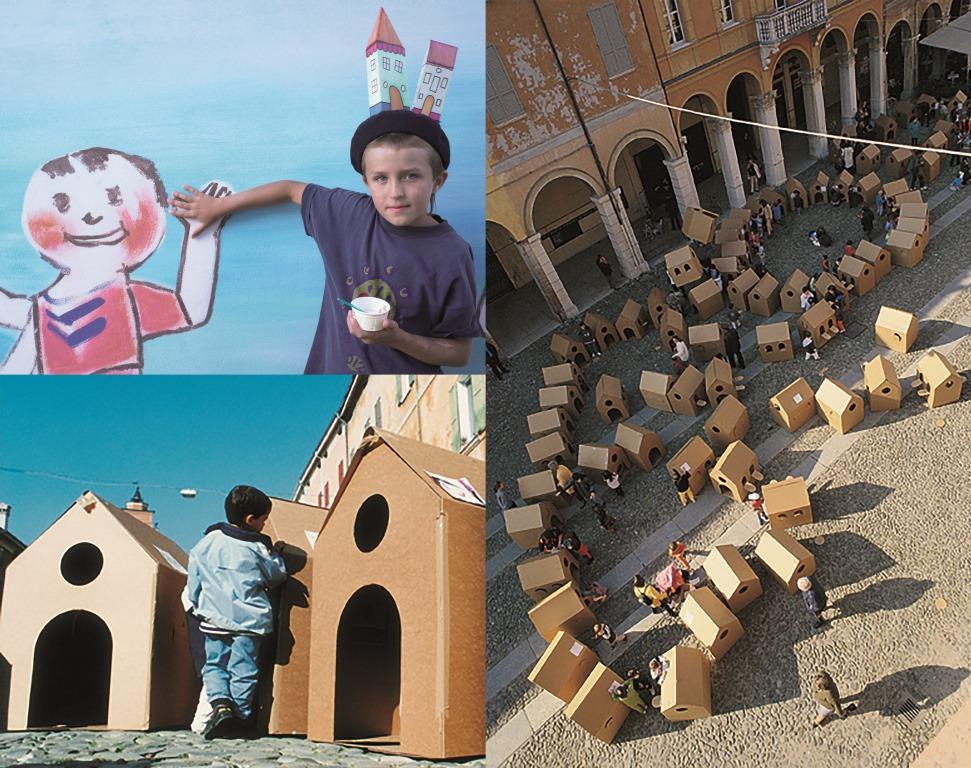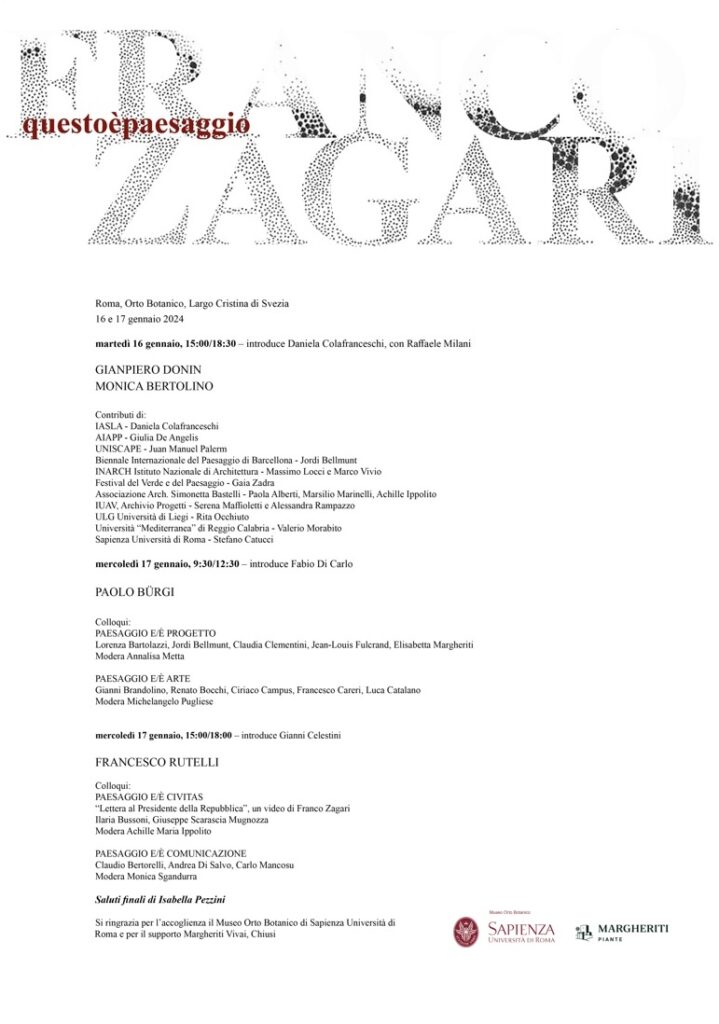
Orto Botanico – Roma, 17-18 gennaio 2024. In onore di Franco Zagari
Questo è paesaggio
Intervento di Andrea Di Salvo
La valenza tutta politica e vorrei dire sovversiva del paesaggio emerge rivelata dalle tante preziose bellezze che indossa come anche dalle tante cicatrici che scopre. Valenza politica da leggere tanto nell’urgenza degli avvenimenti dell’oggi quanto nella placida irrequietezza, di quei tempi lunghi che ci è così difficile assumere come misura
il Paesaggio è questione politica e, proprio nella sua irriducibilità a definizioni chiuse con cui Franco ha da sempre condotto il suo corpo a corpo, è uno strumento che ha la plasticità per interagire, davvero, con la complessità di un reale in continuo divenire.
Interagire, come forse non riesce più tanto la politica, per come almeno la abbiamo a lungo pensata (Collana Habitus, Deriveapprodi editore).

Per rendersi conto della pervasività con la quale vien chiamato in causa il concetto di paesaggio, basta verificare frequenze di utilizzo e occorrenze del termine in tanti ambiti diversi. Un utilizzo che quasi sempre finisce però per esser precisato, declinato…con un aggettivo. O molto spesso per essere impiegato in senso traslato. Paesaggio urbano, paesaggio sonoro, paesaggio interiore, della guerra, paesaggio del vino, paesaggio educativo, paesaggi dell’aldilà
I rischi più evidenti sono la perdita di pregnanza e la sovraesposizione.
Sempre più spesso al paesaggio si chiede di prefigurare per supplenza un modello sostitutivo di società verso cui orientarsi.
Altro rischio è la tendenza all’accaparramento in esclusiva del paesaggio, una ortodossia dell’uso da parte di alcuni (rischio dal quale ovviamente, non vanno esenti neanche i paesaggisti).
Quindi, paesaggio come questione politica. Ma le crisi che di questi tempi constatiamo numerose, spesso esito di una globalizzazione che procede omologando e che al tempo stesso però frammenta e sradica territori e singolarità, queste crisi son prodotte non tanto dall’uomo in astratto (quello dell’antropocene), quanto da specifici modelli di dominio storicamente determinati.
Il paesaggio ci aiuta a Interrogarci su cosa oggi qualifichi il nostro con-vivere, il nostro abitare, cosa costituisca il nostro ben essere.
Domande che abbiamo finito per porci sempre più di rado. Forse considerandole ovvie. Perché immersi in una dominante dimensione produttivo-consumistica, che finisce per assecondare lo status quo, pretendendoci semplici consumatori, osservatori passivi.
La vitalità euristica, conoscitiva, del paesaggio, resta invece legata al suo esser generatore di interrogativi, piuttosto che non risposta univoca.


Credo siano parole di Franco Zagari, o da lui ispirate quelle che auspicano un approccio non tanto teso a risolvere i problemi, quanto a lavorare ai loro margini: “porsi accanto” a un processo cognitivo dove intuito e esperienza giocano in armonia nell’elaborare … in base a ibridazioni e incertezze; “spostare” i termini di lettura da piani consueti a piani creativi.
Per altro verso, il paesaggio, come sempre Franco più occasioni ci ha in mostrato nella pratica, non può mai dirsi neutrale.
È questione politica – e, proprio per questo, presuppone di affermarsi soltanto insieme al diffondersi di una “cultura del paesaggio”.
Cultura del paesaggio che presuppone una educazione alla consapevolezza del paesaggio. Consapevolezza non scontata, anzi tutta da enucleare e alimentare
A fronte di un analfabetismo che malgrado tanti sforzi nell’ambito della formazione, superiore, tecnica e universitaria, nell’universo comunicativo di studiosi e appassionati sui più vari media e sui territori, in alcune filiere del florovivaismo, nell’attivismo dei singoli e delle associazioni, si misura dal rilievo – diciamo così – e dalla presenza del tema del paesaggio nel senso comune, perlopiù nelle cristallizzazioni discorsive che lo riducono a oggetto di conservazione e decoro, valorizzazione; marketing, marchio per identità di luogo, volano per consumi culturali, ostaggio di leggi e decreti applicativi che ne ignorano le grammatiche e la sintassi del progetto.
Come avviene per le piante (che riusciamo a vedere soltanto come uno sfondo indistinto su cui si stagliano protagonismi altri) così pure, si può parlare di cecità del paesaggio. Di un analfabetismo, anche affettivo nei suoi confronti. Con l’aggravante della distorsione di vivere ormai buona parte del nostro percepire il mondo attraverso uno schermo.
Il paesaggio si fa carico invece di una dimensione sempre più spesso omessa. Quella corporale, Il rapporto diretto, immediato, fisico con gli elementi sensibili del mondo terrestre. Il paesaggio è esperienza polisensoriale.
Prima di vederlo, noi abitiamo un paesaggio. L’esperienza sensibile del paesaggio si dilata oltre la concezione puramente “visuale”. Per quanto tutt’ora egemonica.
Occorre considerare l’intrinseca psichicità del movimento che non accetta separazione tra sensoriale, motorio, cognitivo. L’invito è a considerare una spazialità del contatto, della partecipazione con l’ambiente esterno (Besse). Mentre si parla di Mindscape (Lingiardi).
L’esperienza del paesaggio è un’esperienza primaria, che accade nel corpo, precede il linguaggio. Perciò il paesaggio è una delle fonti di quel sapere implicito che vien prima della coscienza e della ragione, generatore di Habitus (Regni).
Abitare un paesaggio è condizione del nostro stare al mondo. farne parte significa che lì attingiamo la nostra identità
Siamo Corporalità in movimento.
Dalla vita cellulare totipotente alle molte contemporaneità del paesaggio di cui ci dice Massimo Venturi Ferriolo, tutto è movimento. Anche se su scale e velocità tra di loro diversissime
Certo, corporalità in movimento, in relazione a un punto di visuale.
Con una metafora abusata si può ben evidenziare come, se il mondo visto dal finestrino di un noi in movimento accelerato ci sembra che fugga sempre a gran velocità, questa condizione va assieme alla fissità del vincolo del punto di vista. La fissità obbligata dello sguardo [a gran velocita non ci possiamo auspicabilmente distrarre] e del dover continuamente riconfigurare in un senso, in una sintesi di senso ciò che andiamo vedendo consapevoli che molto in ogni caso sfugge: in una obbligatoria accettazione del limite.
Rallentando…, si tratta di quel che vien chiamato sapere paesaggistico (Besse), qualcosa di più di un’intelligenza pratica quotidiana del mondo e dello spazio, una familiarità fondata sull’uso.
Quel che si diceva prima è che occorre portarla a consapevolezza. Fino a attingere una responsabile consapevolezza del nostro scegliere ad ogni passo una direzione: agire comunque, anche se talvolta vorremmo illuderci che a ciò è possibile sottrarci – il famoso quanto costa non fare, di Franco Zagari.
Tutta fondata sulla relazione è quindi una possibile, auspicabile etica dell’azione del paesaggio – che alcuni ritengono addirittura “consustanziale al paesaggio” (Brunon).
Un’azione-reazione, un tipo di corrispondenza che per il tramite del paesaggio (prima ancora, del giardino) intratteniamo con il mondo.
Una relazione paesaggistica che lega in modo interattivo e interdipendente società e paesaggio, le cui pratiche implicano una tessitura continua di connessioni tra noi stessi, le nature del vivente, il territorio.
Così, Il tema del paesaggio (e del giardino) irrompe nell’ambito delle ricerche che variamente si rifanno agli Environnemental studies che nell’analisi della società intendono includere il non umano: in un dialogo fra vari generi di persone: alcune umane, altre non umane, persone senza differenziazioni ontologiche gerarchiche.
Un dialogo basato piuttosto su parentele e solidarietà che non su separazione e dominazione, fatto di pratiche che, sperimentando un continuo, inesausto negoziato, sempre alla ricerca di equilibri, definiscono appunto un modo di essere al mondo nei termini relazionali di un mutuo determinarsi attraverso attenzione e reciprocità, una mutua “rispettosa amicizia”.
Persone tutte: come quando, quasi a farsi teatro (Turri), il paesaggio, allargato ad agenti umani e non umani, esprime e sintetizza la trama di queste relazioni, ospitandole. Ma essendo al tempo stesso interprete e implicato co-protagonista lui stesso, in qualità di paesaggio-soggetto, con una sua qual certa autonomia, cui riconoscere statuto personale.
Tra le tante lezioni di Franco ritorna spesso l’invito a partir sempre assumendo le molteplicità del paesaggio: di questo sistema vivente di relazioni sempre in divenire, al tempo stesso strumento di lettura dell’insieme, opportunità del convergere di pensiero e azione, sfida tesa alla costruzione progettuale, sociale, politica. Mai neutrale.
E, oltre l’incrementale ansia definitoria – spesso pervasa da una nota lieve di fertile ironia – l’invito di Franco Zagari all’accettazione anche dei tratti contraddittori di fisionomie stravolte. E quello a considerare il paesaggio nel suo continuo evolversi, trasformarsi e quindi nella sua costitutiva contemporaneità.
Contemporaneità che Franco ha contribuito a render viva, attuale, in un gioco continuo di bilancio e rilancio. Con la sua spiccata vocazione alla sperimentazione (che Franco condivideva con il paesaggio), il suo muoversi sul confine di diversi saperi; il suo piacere di ibridare esigenze, vocazioni, narrazioni, senso condiviso, autorappresentazioni, linguaggi della contemporaneità, suggestioni delle arti.
Ma sempre in un procedere che privilegia lo studio delle relazioni più che non dei singolari oggetti in sé.
E sempre affinando il prediletto grimaldello del progetto: strumento-estensione-evoluzione plastica, che concorre a strutturare la percezione e il pensiero umano per modificar l’ambiente: si potrebbe dire: qualcosa che viaggia sullo stesso filo di quello stretto, ancestrale rapporto mano-pietra (che, secondo l’archeologia cognitiva di Lambros Malafouris, presiede alla fabbricazione di selci come strumenti litici da parte dei nostri progenitori).

Ma qui mi fermo. Sarà meglio.
E vi saluto con alcuni versi di una poesia di Valerio Magrelli che ogni volta mi fa pensare a Franco, in tanti modi diversi: è parte di un testo apparso in Nature e venature, del 1987.
Versi che isolo a partire da uno strumentale riferimento al fumo.
Fumo che però, in questo caso, evoca piuttosto, l’aura di ciascuno, la nostra anima, e di certo il nostro anelito.
Versi che dicono
Io cammino fumando
e dopo ogni boccata
attraverso il mio fumo
e sto dove non stavo
dove prima soffiavo.
Il titolo della poesia recita E mi meraviglio
E questo sorprenderci, sempre in un altrove rispetto a dove lo si aspetta, era per me il tratto più “rasserenante”, anche affettivamente parlando, di un Franco che si sperperava spesso con lieve grazia gratuita
Grazie a tutti e a Franco
Andrea Di Salvo