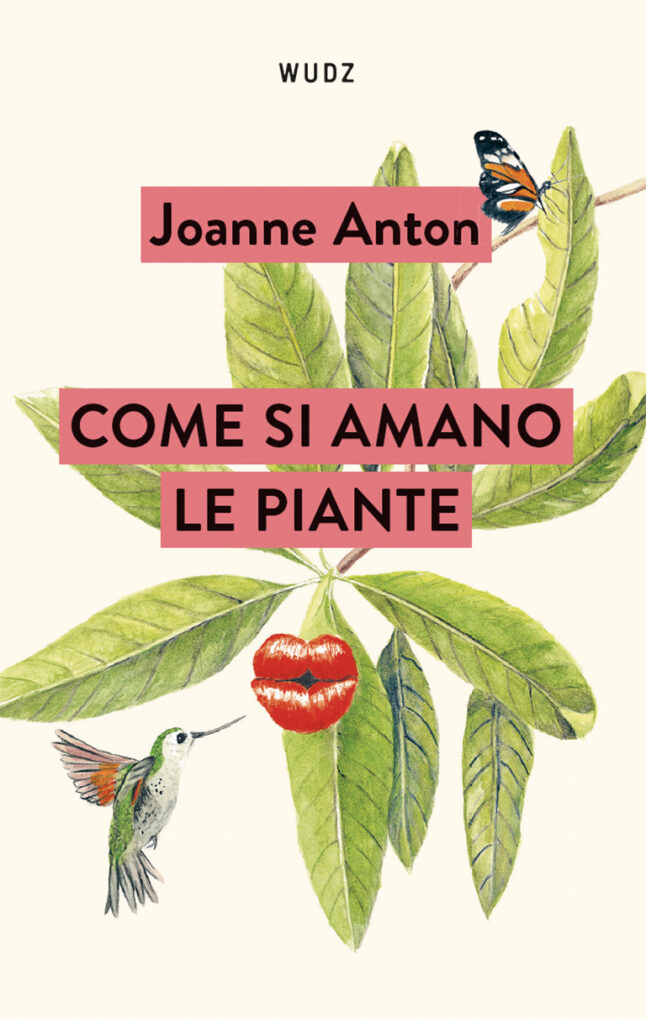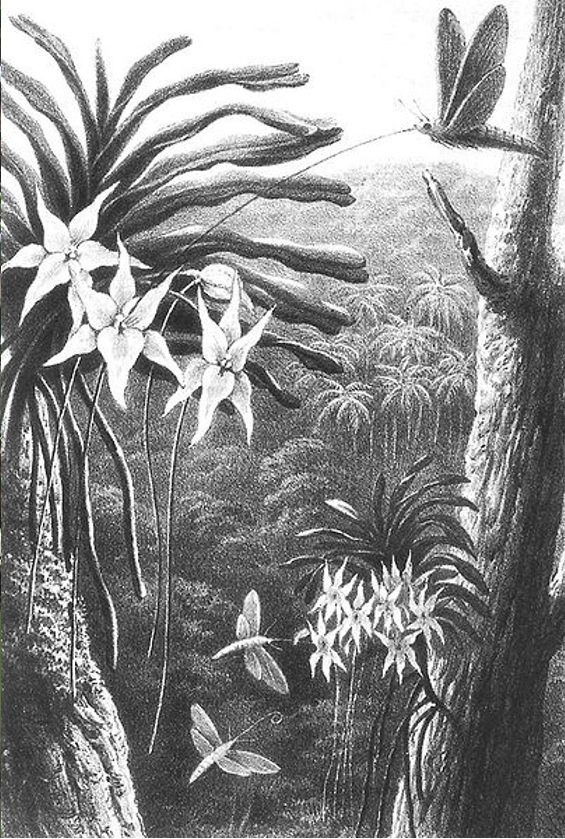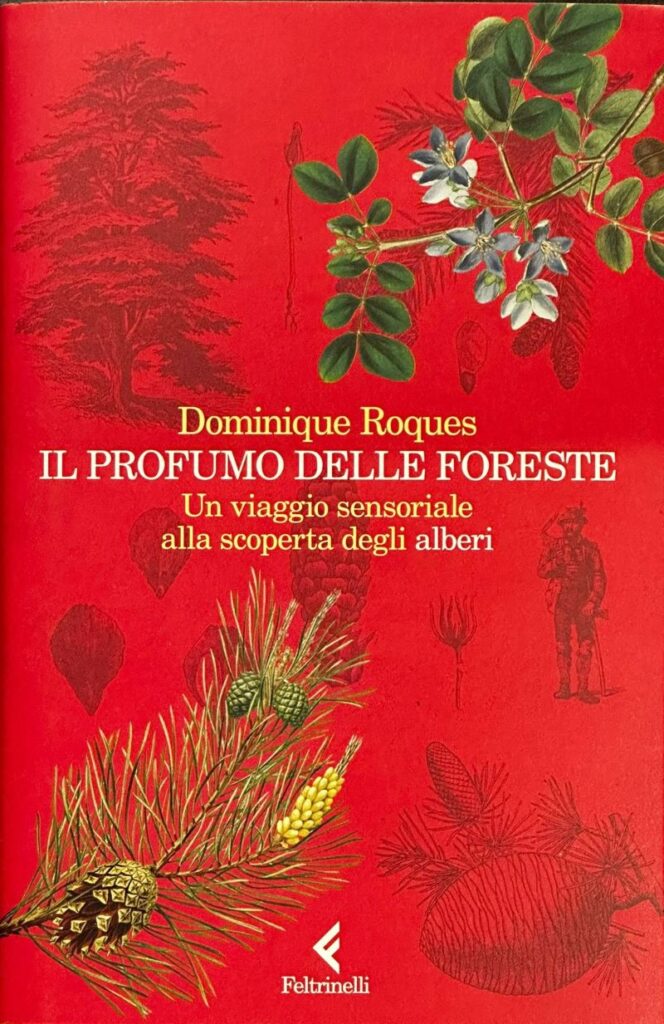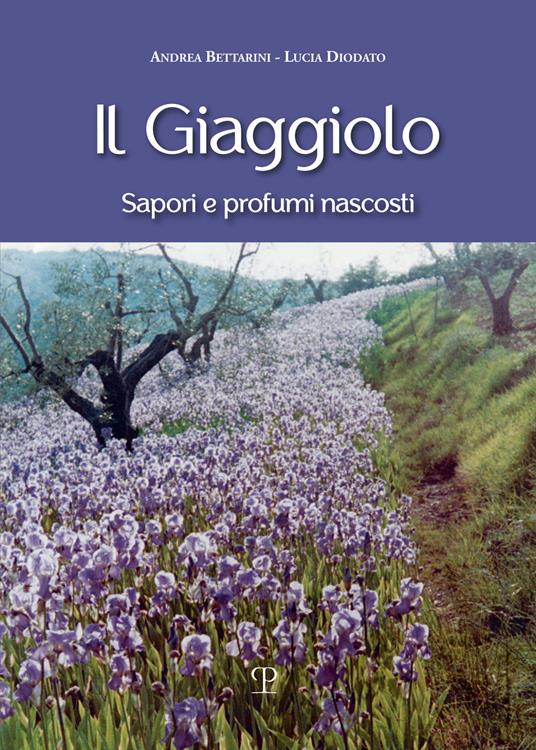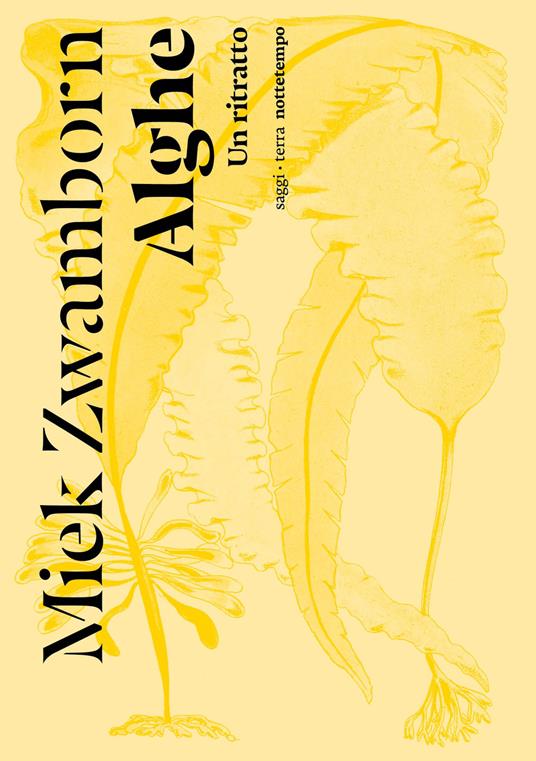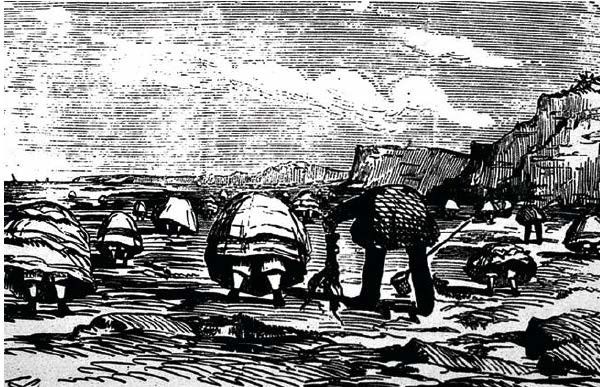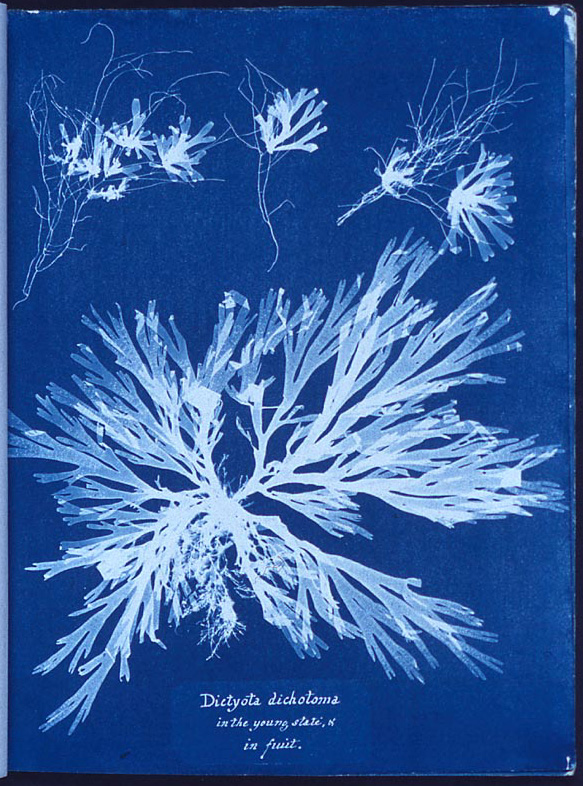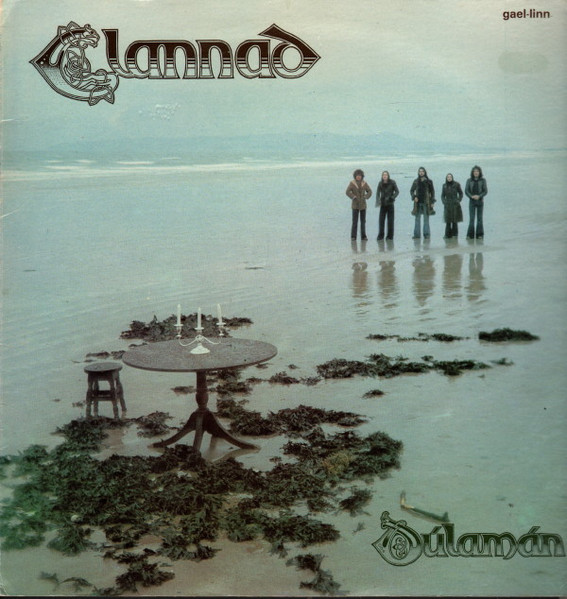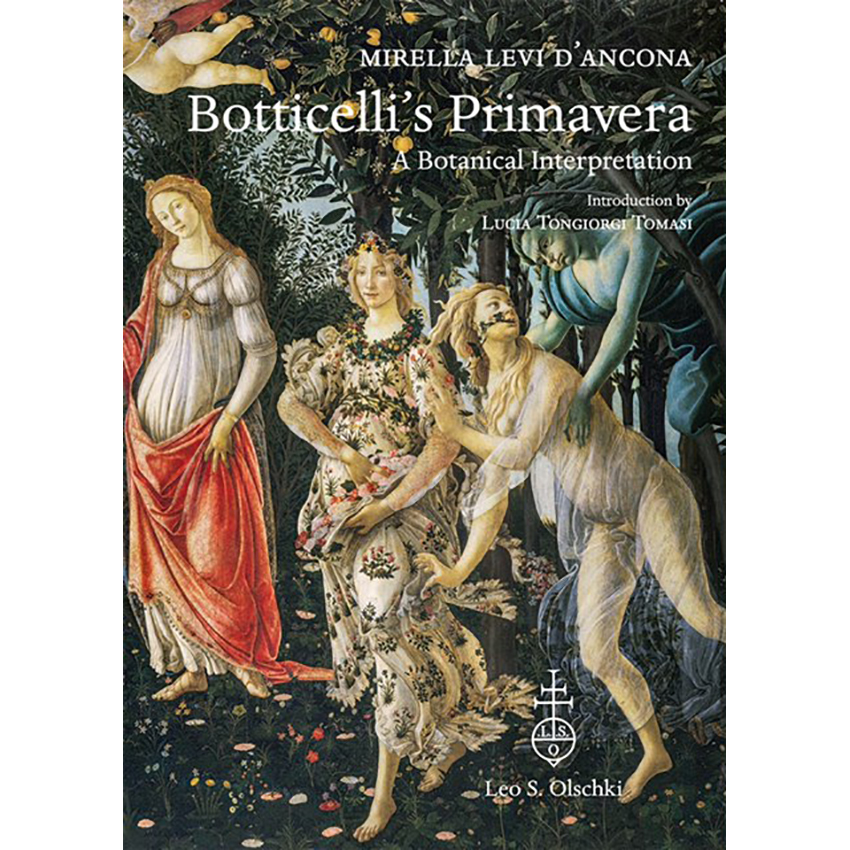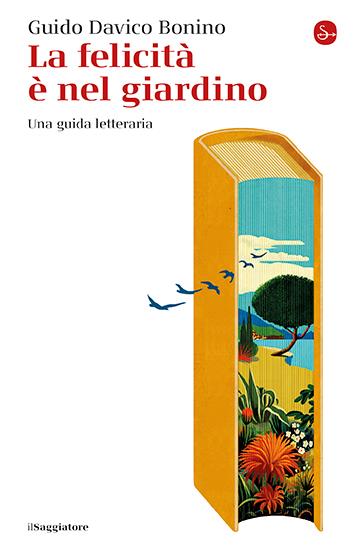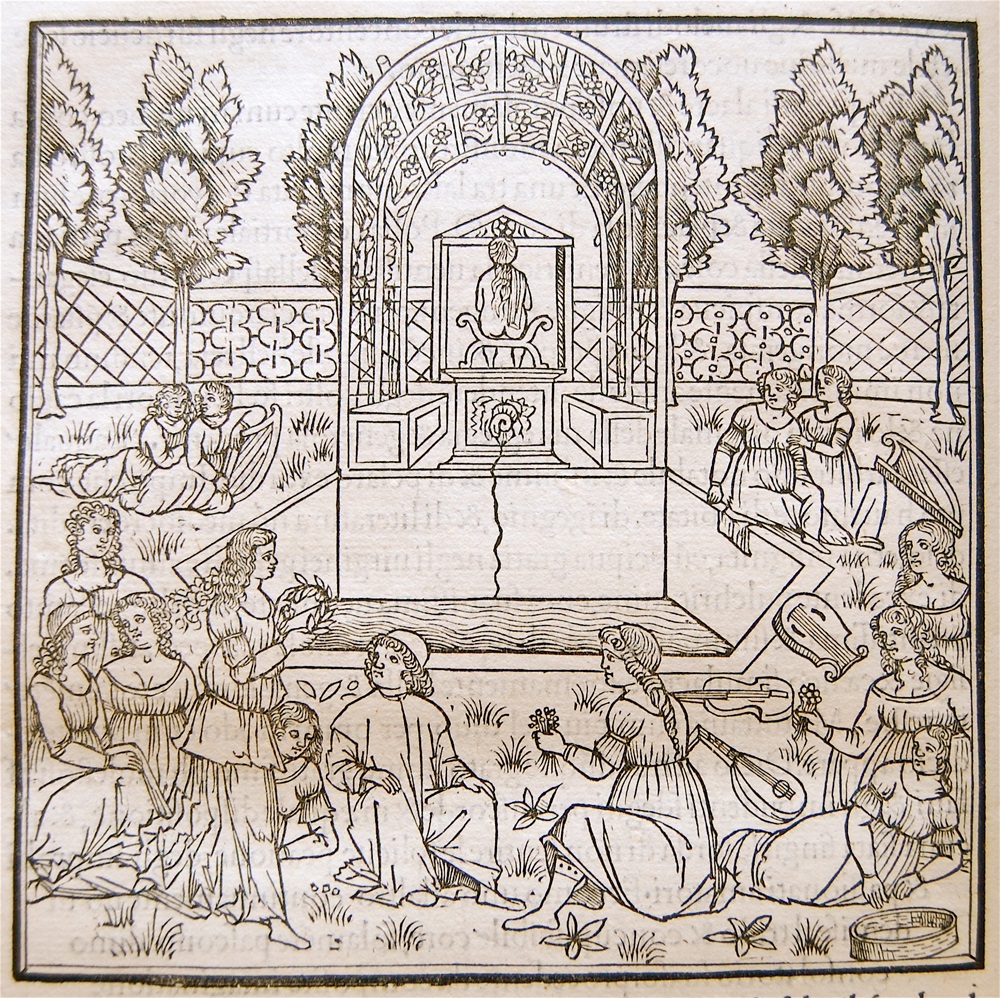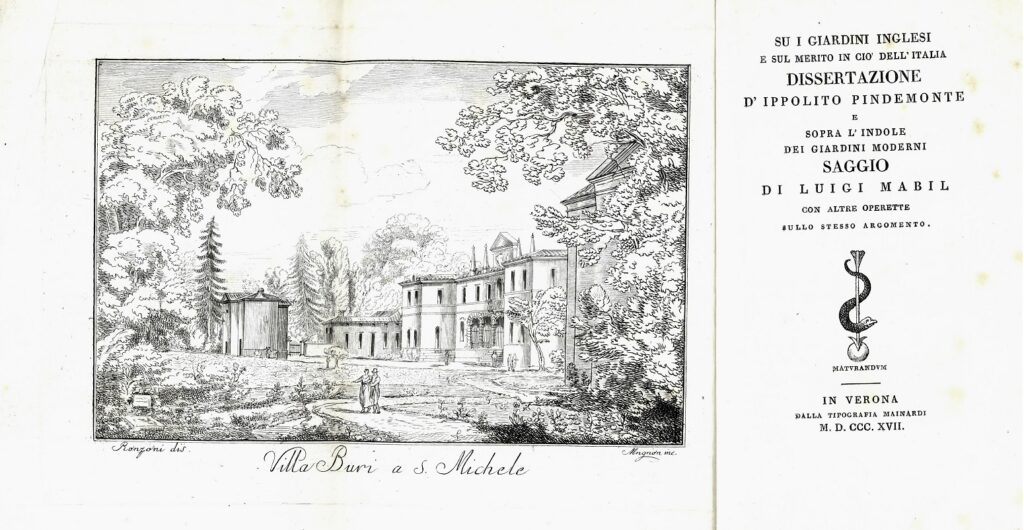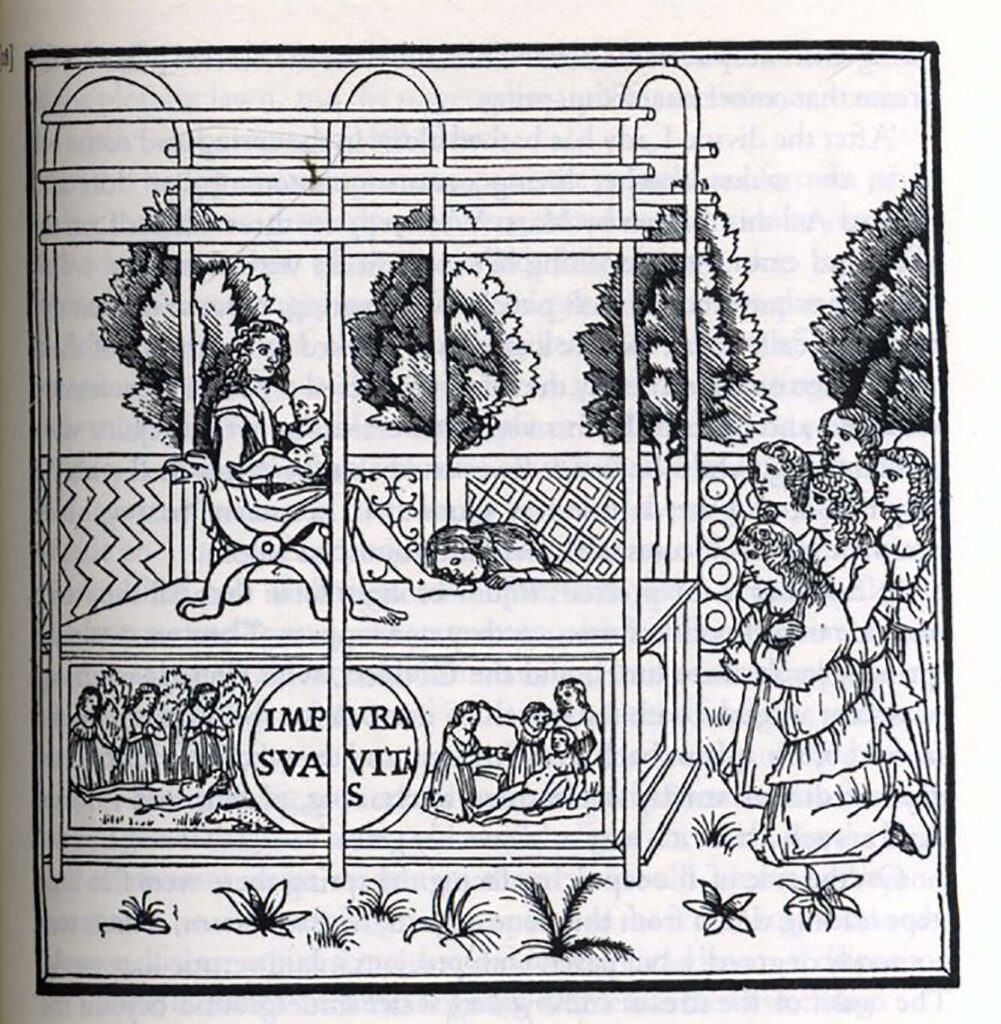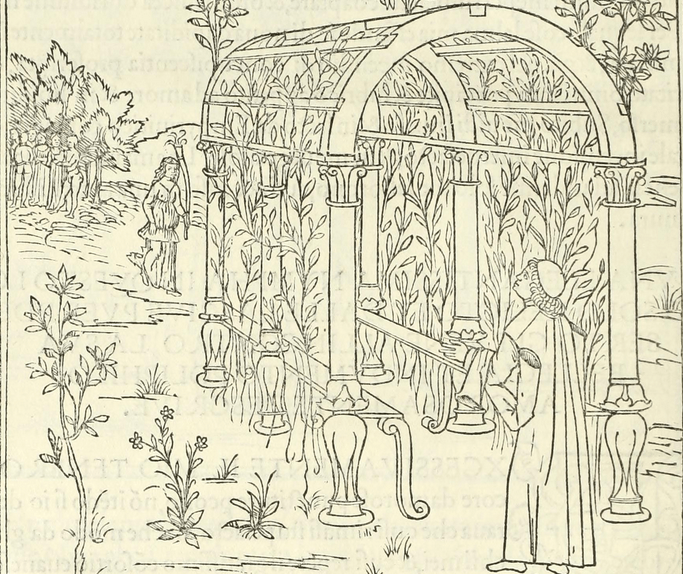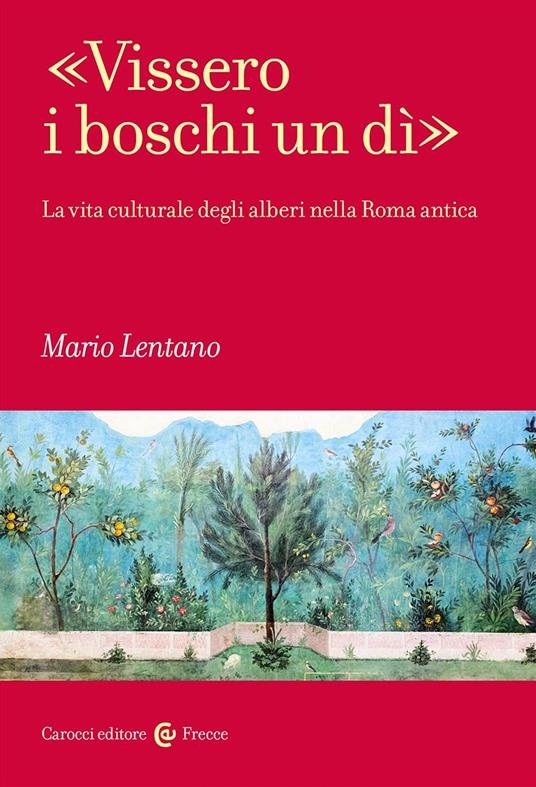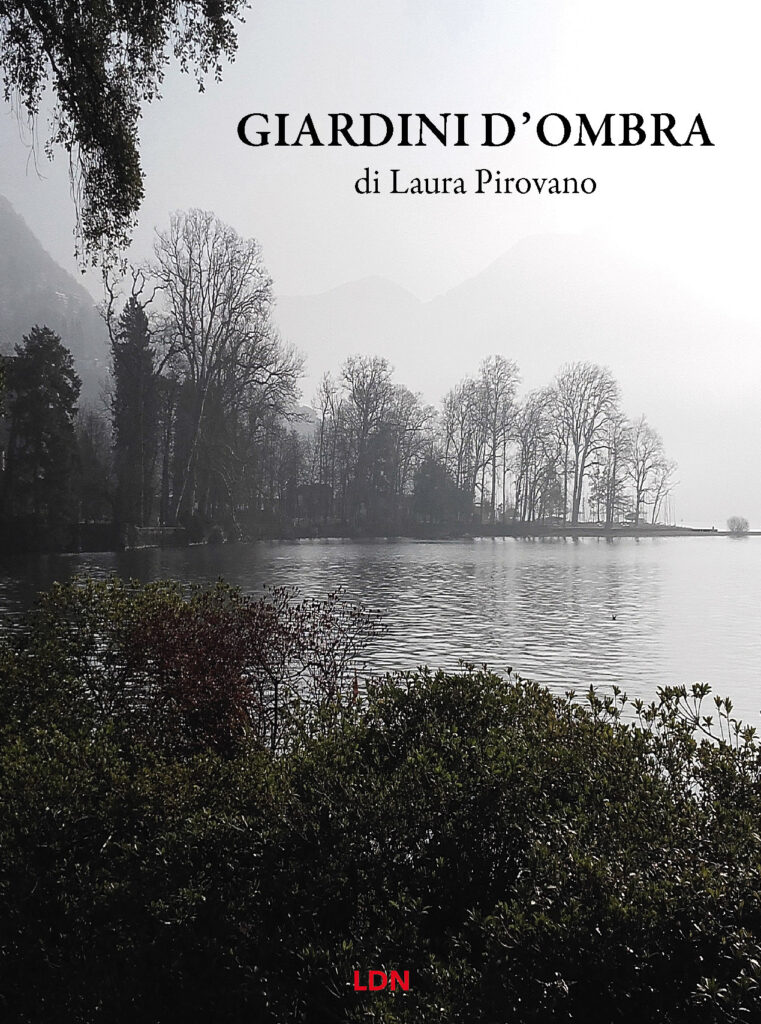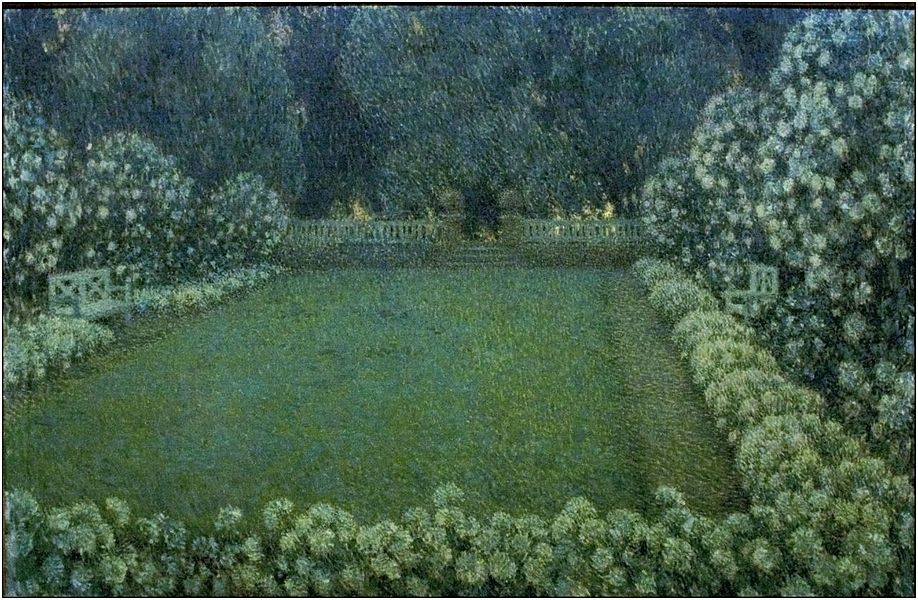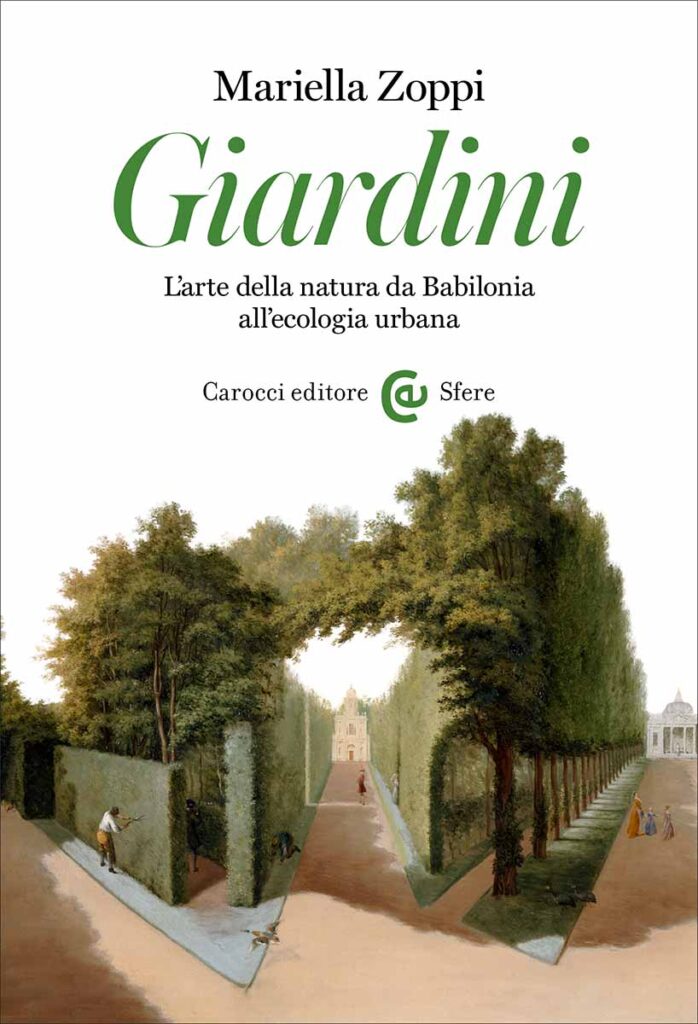
A fronte del persistente ritorno di interesse per forme e qualità del nostro esser parte e in relazione con la natura nonché per il ruolo di mediazione che in quest’ambito il giardino ha da sempre svolto, oggi con particolare efficacia inventiva, torna utile la proposta del ponderoso volume, oltre le mode, dove una specialista come Mariella Zoppi pur non discostandosi dal tradizionale impianto delle storie di giardini e dalla sua precedente sintesi, riprende e riordina questa vicenda come prisma di lettura, nelle sue molte interrelazioni, di una universale storia culturale (Giardini. L’arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana, Carocci, pp. 445, € 35,00).
Per il tramite dell’analisi di realizzazioni e progetti emblematici – particolarmente interessante al riguardo il racconto dei secoli più recenti, per quanto ci si arresti sulla soglia di un contemporaneo davvero ricco di variabili da indagare – il volume si sofferma in puntuali ricostruzioni documentarie di direttrici, snodi, sentieri interrotti. Con la scrittura godibile di chi soprattutto intesse relazioni evidenziando filiazioni, analogie e concause, incrocia, per ambiti geografici ed egemonie culturali, estetiche e verticalità politico-istituzionali – dove modi e stilemi sembrano inseguirsi, come in una sorta di passaggio di testimone, per via di debiti e reinterpretazioni – con tematiche sovraordinate, per come in forme diverse di declinano nei diversi contesti.
Così, per dire, è nella congerie dei dibattiti di inizio Novecento sul tema della casa e della città, che si assiste al ripensamento del rapporto fra abitazione e giardino che figura da allora come componente estesa e unificante dell’intero sistema abitativo. E alcune importanti esperienze urbanistiche e paesaggistiche (la Grande Helsinki nel 1918 e, nel 1915, il concorso pubblico per il Cimitero nel Bosco (Skogskyrkogården) a Enskede, nei pressi di Stoccolma) anticipano l’esperienza scandinava del funzionalismo che individua poi il parco come luogo d’incontro per tutti, sintesi di natura e cultura, con interventi dalla forte valenza sociale ed educativa (Carl Theodor Sørensen).
Mentre, ben altrimenti il rapporto tra il giardino e avanguardie, specialmente il cubismo, dall’Esposizione universale di Parigi del 1925 con il giardino con alberi di cemento di Robert Mallet-Stevens e quello, inaccessibile, di “d’acqua e di luce” di Gabriel Guévrékian, segnala un atteggiamento di rifiuto dell’imitazione della natura, geometrizzata invece e da metter sotto controllo (i fratelli Vera), un fenomeno come il fascino per il giardino Mediterraneo vien seguito nelle sue molteplici declinazioni. Dalla passione botanica, specialmente per l’esotico, dei giardini di acclimatazione di ville su rive, isole e laghi – con le atmosfere moresche evocate dalla riscoperta dell’Alhambra e dalla passione dei viaggi in Africa –, alle rivisitazioni rinascimentali e neoclassiche in singolare connubio tra stile vittoriano e giardino all’italiana aperto sul paesaggio di una Toscana dove la comunità straniera si affida specialmente a progettisti inglesi come Geoffrey Scott e Cecil Pinsent. Ma anche sul filo del recupero di un antico fuori dal tempo con il ridisegno del sistema dei tracciati di accesso al Partenone del greco Dimitris Pikionis (1887-1968), o nel rilievo dell’esperienza degli architetti modernisti di Barcellona, in particolare Nicolás María Rubió y Tudurí, tra classicismo, identità culturale, naturalità e un’attenzione botanica per specie autoctone ed esotiche o, ancora, invece, nel quadro delle nostalgie della lettura fascista di un Giardino italiano esaltato e disciplinato sotto la guida di Ugo Ojetti nella grande mostra fiorentina del 1931.
Se poi, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento si afferma il tema della rilevanza e specificità della presenza femminile nella storia del giardino, questo si intreccia con il nodo della formazione, di un orientamento oltre l’approccio amatoriale – specialmente nell’esperienza statunitense – più tecnico-scientifico, mirata allo svolgimento di una professione (del 1922, la fondazione del Glynde College for Lady Gardeners). Con l’istituzione a New York nel 1899 della American Society of Landscape Architects, e Beatrix Farrand unica donna tra i diciannove fondatori, si afferma una scuola paesaggistica, dove, dopo la grande crisi, un nuovo carattere identitario propugna la sintesi tra edificio e il suo intorno, una forte continuità fra interno ed esterno, una complementarità strutturale fra architetture e ambiente che si estende alle diverse scale. Un modo di operare dell’architettura del paesaggio come risposta a un’esigenza sociale nel segno del miglioramento degli ambienti di vita.
Così, dall’ideale – tradotto in giardino – della vita di campagna di età postvittoriana, come già prima dall’arte di progettare la natura emblematica del giardino paesaggistico inglese, si arriverà a porsi nel XXI secolo il tema della cura dei luoghi.

Dove rispetto al diverso graduarsi di “formale” e “naturale”, conta piuttosto la capacità di accompagnarli e interpretarne la dialettica, fin sulla scala territoriale.
Assumerne, in proiezione, una presenza diffusa, capillare e pervasiva, dove ogni segmento di verde si pone come tessera di un mosaico sistemico, ospite di interazioni complementari, impone di ripensare l’idea stessa di giardino, oltre il recinto.
“Alla fine del XX secolo, pur nelle differenze di clima, culture e tradizioni, l’arte del giardino non è più riferibile ad ambiti specifici”. Installazioni artistiche, esperienze partecipative di sistema (il Superkilen di Copenaghen), uso di piccoli spazi residuali, sistemazioni temporanee, sovente spontanee e partecipate, recupero della memoria dei luoghi, si innestano in una sorta di continua sperimentazione di soluzioni a problematiche condivise dove più che l’adesione a specifiche tipologie o soluzioni formali, conta tradurre aspirazioni verso nuovi modelli dell’abitare.
In una generale riqualificazione ecologica, presupposto progettuale di una urbanità imperniata sullo spazio pubblico.
Mariella Zoppi, Giardini. L’arte della natura da Babilonia all’ecologia urbana, Carocci, pp. 445, € 35,00, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XIV, 23 Supplemento de Il Manifesto del 7 luglio 2024